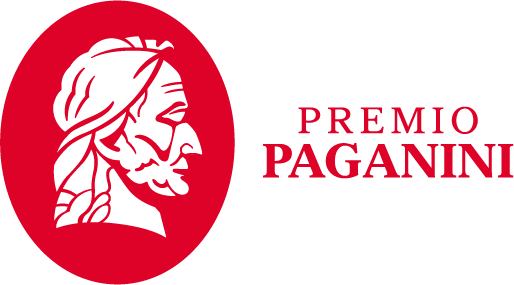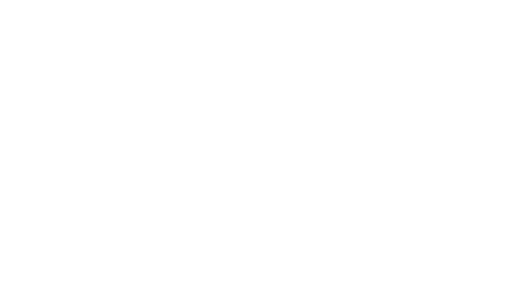EMIRI KAKIUCHI
EMIRI KAKIUCHI
La violinista Emiri Kakiuchi, 19 anni, ha vinto il secondo premio e tre premi speciali al 42° Concorso Internazionale di Violino Rodolfo Lipizer nel 2023, risultando la partecipante più giovane di quell’edizione. In seguito ha tenuto un recital in Italia. Ha inoltre ottenuto il primo premio alla 70ª edizione del Concorso All-Japan Student Music Competition (sezione di Nagoya), il secondo premio al Concorso Internazionale di Violino Grumiaux, ed è stata finalista al Concorso Louis Spohr. Altri riconoscimenti includono il quarto premio al 93° Japan Music Competition e il primo premio con premio del pubblico al Munetsugu String Quartet Competition.
Si esibisce regolarmente insieme al fratello Kyota Kakiuchi, con il quale ha debuttato nel 2023 alla Munetsugu Hall e successivamente al GIFU-KANO International Music Festival, accanto a membri dei Berliner Philharmoniker.
È stata in passato spalla dei secondi violini della Super Kids Orchestra diretta da Yutaka Sado. Ha studiato alla Yehudi Menuhin School con Akiko Ono e attualmente prosegue gli studi presso la Università delle Arti di Berlino con i professori Nora Chastain, Victoria Wong e Vineta Sareika. Suona un violino di Santo Serafin del 1725.
1. C’è stato un momento o un’esperienza specifica che ti ha fatto capire di voler diventare musicista?
Avevo circa quindici anni quando assistetti a un concerto alla Yehudi Menuhin School, dove Sasha Sitkovetsky eseguì la Sonata di Franck. Quella serata fu per me una vera rivelazione: fu la prima volta in cui compresi davvero il potere emotivo della musica. Fino ad allora avevo vissuto la musica come qualcosa da studiare, perfezionare e suonare. Mi piaceva, certo, e apprezzavo la bellezza e la complessità del repertorio che affrontavo. Ma quella performance cambiò tutto. Il modo in cui Sitkovetsky suonava non era solo tecnicamente impeccabile, era profondamente espressivo. Non sembrava un'esibizione, ma un flusso di emozione pura, un collegamento diretto e sincero tra musicista e ascoltatore. Ricordo di essere rimasta immobile, quasi senza respirare. Era come se la musica fosse entrata dentro di me e avesse aperto qualcosa che nemmeno sapevo di avere. Mi sono sentita vista, commossa, completamente assorbita. La sonata parlava una lingua che andava oltre le parole e diceva qualcosa di profondamente umano.Quel momento mi è rimasto dentro da allora. È stato un punto di svolta, un attimo di totale chiarezza. Ricordo di aver pensato: “È questo quello che voglio fare. Voglio far sentire gli altri come mi sono sentita io.” Volevo capire come usare la musica non per impressionare o intrattenere, ma per raggiungere le persone a un livello emotivo autentico. Quella performance mi ha mostrato ciò che è possibile: la musica può essere molto più di note su uno spartito o suoni in una sala — può essere una salvezza, uno specchio, un’esperienza condivisa. Da quel momento, ho iniziato a vedere la musica come un linguaggio di comunicazione, e da allora il mio rapporto con essa è guidato da questa visione.
2. Quando ti esibisci, cosa speri di comunicare o far provare al pubblico?
Che si tratti di gioia, dolore, stupore, tensione o persino risate, il mio desiderio è creare uno spazio dove le persone possano sentire qualcosa in profondità. Le emozioni sono ciò che ci fa ricordare i momenti.
3. Se dovessi presentarti suonando un solo brano di tutto il repertorio, quale sceglieresti e perché?
Sceglierei il Quartetto per archi n. 6 in fa minore, op. 80 di Mendelssohn. È un’opera profondamente commovente e intensa, che ogni volta riesce a toccare corde profonde dentro di me. Quando lo suono, resto sempre colpita da quanto riesca a rappresentare l’emozione umana nella sua forma più cruda — dolore, rabbia, nostalgia e, a tratti, brevi lampi di speranza.
Composto dopo la morte della sorella Fanny, Mendelssohn riversò in questo quartetto tutta la sua sofferenza e disperazione, e quell’intensità emotiva attraversa ogni nota.
Quello che rende questo brano particolarmente significativo per me è il modo in cui rafforza l’intesa all’interno del mio quartetto. Quando lo eseguiamo insieme, si crea un senso di unità, una connessione emotiva condivisa. L’urgenza del primo movimento, il lirismo struggente delle sezioni lente e l’energia travolgente del finale richiedono non solo precisione tecnica, ma un impegno emotivo totale da parte di tutti e quattro.
In quei momenti — quando respiriamo e fraseggiamo all’unisono — sento davvero il potere della musica da camera. Suonare questo quartetto è allo stesso tempo catartico e ispirante. Mi ricorda quanto in profondità possa arrivare la musica, come superi le parole e parli direttamente all’anima. Ci mette di fronte alla vulnerabilità, ci spinge ad aprirci al dolore e alla bellezza che vivono in queste note, e a comunicare tutto questo con onestà.
L’op. 80 di Mendelssohn non è solo un capolavoro — è una testimonianza dello spirito umano, e mi sento incredibilmente fortunata a poter esplorarne i significati insieme al mio ensemble.